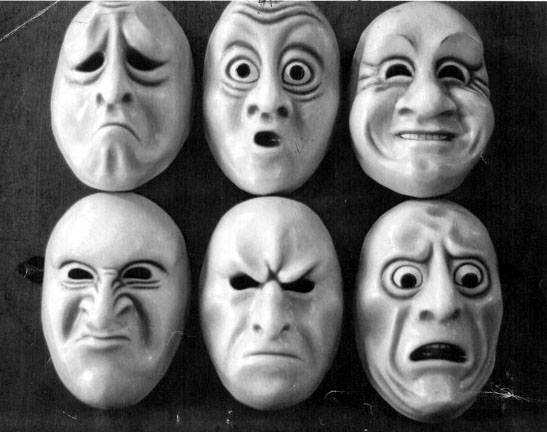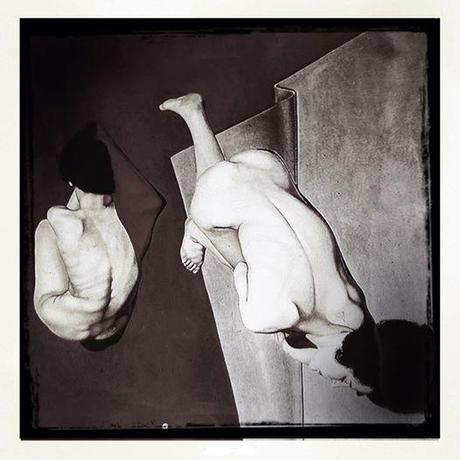* * *
"La bigenitorialità non esiste.".
Qualche mese fa, invitato ad un convegno sul tema, così mi venne da esordire, contribuendo alla rianimazione dei tanti astanti, ormai un po' assonnati, in quel pomeriggio di inizio primavera.
Al di là della boutade, che non può mancare in ogni sana dissertazione, per di più dopo la pausa pranzo, la questione è più che seria e merita, nel pur breve spazio di questa prefazione, il suo approfondimento; soprattutto se il preambolo del caso anticipa un’intensa e meticolosa analisi (
il libro di Foti e Targher) su un oggetto che, apparentemente (ma solo apparentemente), la bigenitorialità sembrerebbe metterla in discussione: il divorzio -ancor più in quello specifico che pertiene alla relazione coi figli.

L'intervento clinico, oramai più che decennale, con famiglie in situazione di disagio (da crisi coniugale e separazione, compresi), mi obbliga ogni giorno a riflettere (e intervenire) attorno al radicale cambiamento che negli ultimi anni ha trasformato i rapporti interpersonali, stravolgendo, a cascata, ogni configurazione relazionale che fino a ieri supportava (e, certo, spesso, sopportava) una certa stabilità.
Le ragioni di questa trasformazione sono complesse e non può essere questo il luogo per disciplinarle. Ci basti sapere che, se fino al 1989 (anno della
Convenzione sui Diritti del Bambino di New York) il concetto di bigenitorialità riferiva, ai non addetti, per lo più la sua declinazione di stampo biologico; a partire da quella data si è trasferito e diffuso nel campo del diritto: del bambino, a proteggere la necessità di un rapporto continuativo con entrambi i genitori; e dei genitori, a tutelare la possibilità di esercitare il ruolo di padre e di madre.
Il passaggio dalla “scontata naturalità” di una condizione (la facoltà di fare, in egual misura, il padre e la madre e l'esserne, in egual misura, figlio), alla necessità di disciplinare e tutelare giuridicamente tale “naturalità”, racconta da sé il cambiamento. Ma, se tale ridefinizione prendeva allora le mosse dal sempre più diffuso ricorso all'istituto del divorzio e all'urgenza di dare -appunto- il giusto peso a quei diritti delle parti in gioco che le separazioni mettevano (e mettono), nei fatti, frequentemente in discussione; oggi, per una di quelle obversioni tipiche del post-moderno, la situazione sembra completamente capovolta.
Dieci anni prima della Convenzione di New York, un film:
“Kramer contro Kramer”, riscuoteva un successo mondiale (anche grazie ad alcuni facili sentimentalismi), ed apriva diffusamente il sipario su una mutazione in cui il femminile si affermava sempre più concretamente, determinando un riposizionamento del ruolo maschile.
Erano i segnali, estesamente manifesti, di una ridefinizione radicale dei ruoli che certo partiva da più lontano, ma che, proprio in quegli anni, si concretava in una serie di nuove e palpabili esigenze, con conseguenti assestamenti delle pratiche famigliari: marcata conquista, per le donne, di un’indipendenza economica che restringeva il tempo del “fare la mamma” e conseguente riqualificazione delle pratiche maschili, insieme alla spinta ad un rapporto più autentico con i figli, dismettendo gli aspetti più repressivi che ne avevano caratterizzato lo stereotipo, a favore di una gamma di sentimenti più articolata.
E’ da qui che, a mio avviso, il concetto di bigenitorialità comincia ad assumere quel senso extrabiologico che si formalizza nella Convenzione sui Diritti del Bambino, ma in questa non si arresta, e prosegue, di pari passo con le altre metamorfosi sociali, insidiando la famiglia ben al di là dell’evento separativo.
Infatti, il riconoscimento di una bigenitorialità ormai radicata nei riferimenti culturali delle famiglie e la sua conseguente tutela giuridica, non significano -purtroppo- la reale esistenza di quotidiane pratiche educative che la esemplifichino.
Ciò che in larga misura sembra essere successo, a fronte del venire meno della famiglia tradizionale, è, di fatto, la scomparsa della bigenitorialità o, meglio: mentre questa veniva acquisita come principio teorico generale, perdeva di pari passo consistenza fino a determinare, oggi, quella che i sociologi chiamano “la società senza padri”, bizzarra immagine di bigenitorialità.
Il contesto in cui si esplica il rapporto tra genitori e figli sembra, dunque, essere al centro di un processo che si polarizza su due posizioni contraddittorie, spesso autoescludentisi e, comunque, confusive: da una parte il richiamo alla bigenitorilità; dall'altra, la progressiva riduzione e svalutazione delle “naturali” e millenarie pratiche educative bigenitorialmente distinte (per quanto a volte nefaste), sintesi che sembra aver finito per salvare (almeno per ora) un solo modus operandi: quello della madre.
Per bene che vada, dunque, per le molte e legittime ragioni del nostro attuale vivere sociale, questa bigenitorialità, ha per lo più le sembianze del materno: sia quando il padre di fatto non c’è (per indolenza o incompetenza -e, sovente, entrambe insieme), sia quando veste i panni della madre .
Non è certo un caso se i più frequenti e consistenti problemi dei figli sono oggi generati da quella ossessione iperprotettiva che pare albergare nella gran parte delle famiglie e trova la sua sponda educativa nell’archetipo della mamma accogliente evirata dall’argine del padre normante. Liberandoci dell’autoritarismo, abbiamo buttato, è il caso di dirlo, il bambino insieme all’acqua sporca e, senza un argine, il fiume tende a esondare.
La centralità del ruolo materno, così come accennata, non richiama, per altro, soltanto ad una rilettura di un modello maschile che non ha ancora saputo mettersi veramente in discussione superando gli stereotipi del passato (per crearne di nuovi ed efficaci) e, nel dubbio, preferisce o sparire o sagomarsi a un ruolo non suo; ma anche all’esigenza di una ricalibrazione del modello materno che, per necessità o legittimo riscatto, finisce per impossessarsi d’ogni spazio di intervento.
In questo contesto così articolato, la bigenitorialità si attesta, al di là di qualsivoglia naturalità o diritto, come una conquista culturale che, paradossalmente, fatica ad attuarsi soprattutto nelle famiglie unite, dove cioè la “normale” configurazione post-moderna dei ruoli non obbliga ad una riflessione in questo senso.
Culturalmente abiurato, e per fortuna, il vetusto padre-padrone, il maschile sembra faticare a ricavarsi un ruolo autentico e personale che non sia sagomabile al femminile o non si esautori nel semplice cambiare un pannolino, andare al parco coi figli, cucinare o lavare i piatti; bensì capace di immaginarsi quale artefice di un cambiamento generativo in un mondo estremamente differente da quello che, i maschi stessi, hanno disegnato per millenni.
Svuotato nelle sue dinamiche tradizionali, alla ricerca di nuove e possibili identità, il ruolo genitoriale, quando non è assunto quasi esclusivamente dal femminile per virtuale parricidio o abdicazione , al femminile finisce per riferirsi per linguaggi, comportamenti, visioni. Sia in un caso che nell’altro, potremmo dunque parlare di: “monogenitorialità”.
Ed ecco allora l’obversione.
E’, infatti, proprio laddove la crisi famigliare irrompe che papà e mamma frequentemente trovano (possono trovare, se ben accompagnati) l’occasione per mettere in discussione costruttiva e propositiva la loro genitorialità, conquistando un apogeo che la normale routine della vita familiare rischia di negare. Il che non vuol essere uno sprono al divorzio, né significa che le famiglie separate siano “migliori”; dovrebbe invece farci riflettere rispetto alla mancanza di un’educazione alla genitorialità che oggi pare diventare sempre più indispensabile e che solo nell’inciampo della crisi coniugale, può trovare l’occasione di riscoprirsi.
Da qui l’importanza della mediazione e di questo libro che bene la illustra, proprio addentrandosi nel fondamentale campo della relazione coi figli e del come affrontare, con loro, il discorso della separazione; non solo nel minuto spazio della tragica rivelazione, ma tanto più in quel tempo potenzialmente esiziale che è il prosieguo della vita da separati trasformandolo -appunto- nell'opportunità di costruire o ritrovare una genitorialità perduta o mai rivelata, nell'attesa che tale necessità irrompa anche nelle famiglie unite.
* * *
"La bigenitorialità non esiste.".
Qualche mese fa, invitato ad un convegno sul tema, così mi venne da esordire, contribuendo alla rianimazione dei tanti astanti, ormai un po' assonnati, in quel pomeriggio di inizio primavera.
Al di là della boutade, che non può mancare in ogni sana dissertazione, per di più dopo la pausa pranzo, la questione è più che seria e merita, nel pur breve spazio di questa prefazione, il suo approfondimento; soprattutto se il preambolo del caso anticipa un’intensa e meticolosa analisi (
il libro di Foti e Targher) su un oggetto che, apparentemente (ma solo apparentemente), la bigenitorialità sembrerebbe metterla in discussione: il divorzio -ancor più in quello specifico che pertiene alla relazione coi figli.

L'intervento clinico, oramai più che decennale, con famiglie in situazione di disagio (da crisi coniugale e separazione, compresi), mi obbliga ogni giorno a riflettere (e intervenire) attorno al radicale cambiamento che negli ultimi anni ha trasformato i rapporti interpersonali, stravolgendo, a cascata, ogni configurazione relazionale che fino a ieri supportava (e, certo, spesso, sopportava) una certa stabilità.
Le ragioni di questa trasformazione sono complesse e non può essere questo il luogo per disciplinarle. Ci basti sapere che, se fino al 1989 (anno della
Convenzione sui Diritti del Bambino di New York) il concetto di bigenitorialità riferiva, ai non addetti, per lo più la sua declinazione di stampo biologico; a partire da quella data si è trasferito e diffuso nel campo del diritto: del bambino, a proteggere la necessità di un rapporto continuativo con entrambi i genitori; e dei genitori, a tutelare la possibilità di esercitare il ruolo di padre e di madre.
Il passaggio dalla “scontata naturalità” di una condizione (la facoltà di fare, in egual misura, il padre e la madre e l'esserne, in egual misura, figlio), alla necessità di disciplinare e tutelare giuridicamente tale “naturalità”, racconta da sé il cambiamento. Ma, se tale ridefinizione prendeva allora le mosse dal sempre più diffuso ricorso all'istituto del divorzio e all'urgenza di dare -appunto- il giusto peso a quei diritti delle parti in gioco che le separazioni mettevano (e mettono), nei fatti, frequentemente in discussione; oggi, per una di quelle obversioni tipiche del post-moderno, la situazione sembra completamente capovolta.
Dieci anni prima della Convenzione di New York, un film:
“Kramer contro Kramer”, riscuoteva un successo mondiale (anche grazie ad alcuni facili sentimentalismi), ed apriva diffusamente il sipario su una mutazione in cui il femminile si affermava sempre più concretamente, determinando un riposizionamento del ruolo maschile.
Erano i segnali, estesamente manifesti, di una ridefinizione radicale dei ruoli che certo partiva da più lontano, ma che, proprio in quegli anni, si concretava in una serie di nuove e palpabili esigenze, con conseguenti assestamenti delle pratiche famigliari: marcata conquista, per le donne, di un’indipendenza economica che restringeva il tempo del “fare la mamma” e conseguente riqualificazione delle pratiche maschili, insieme alla spinta ad un rapporto più autentico con i figli, dismettendo gli aspetti più repressivi che ne avevano caratterizzato lo stereotipo, a favore di una gamma di sentimenti più articolata.
E’ da qui che, a mio avviso, il concetto di bigenitorialità comincia ad assumere quel senso extrabiologico che si formalizza nella Convenzione sui Diritti del Bambino, ma in questa non si arresta, e prosegue, di pari passo con le altre metamorfosi sociali, insidiando la famiglia ben al di là dell’evento separativo.
Infatti, il riconoscimento di una bigenitorialità ormai radicata nei riferimenti culturali delle famiglie e la sua conseguente tutela giuridica, non significano -purtroppo- la reale esistenza di quotidiane pratiche educative che la esemplifichino.
Ciò che in larga misura sembra essere successo, a fronte del venire meno della famiglia tradizionale, è, di fatto, la scomparsa della bigenitorialità o, meglio: mentre questa veniva acquisita come principio teorico generale, perdeva di pari passo consistenza fino a determinare, oggi, quella che i sociologi chiamano “la società senza padri”, bizzarra immagine di bigenitorialità.
Il contesto in cui si esplica il rapporto tra genitori e figli sembra, dunque, essere al centro di un processo che si polarizza su due posizioni contraddittorie, spesso autoescludentisi e, comunque, confusive: da una parte il richiamo alla bigenitorilità; dall'altra, la progressiva riduzione e svalutazione delle “naturali” e millenarie pratiche educative bigenitorialmente distinte (per quanto a volte nefaste), sintesi che sembra aver finito per salvare (almeno per ora) un solo modus operandi: quello della madre.
Per bene che vada, dunque, per le molte e legittime ragioni del nostro attuale vivere sociale, questa bigenitorialità, ha per lo più le sembianze del materno: sia quando il padre di fatto non c’è (per indolenza o incompetenza -e, sovente, entrambe insieme), sia quando veste i panni della madre .
Non è certo un caso se i più frequenti e consistenti problemi dei figli sono oggi generati da quella ossessione iperprotettiva che pare albergare nella gran parte delle famiglie e trova la sua sponda educativa nell’archetipo della mamma accogliente evirata dall’argine del padre normante. Liberandoci dell’autoritarismo, abbiamo buttato, è il caso di dirlo, il bambino insieme all’acqua sporca e, senza un argine, il fiume tende a esondare.
La centralità del ruolo materno, così come accennata, non richiama, per altro, soltanto ad una rilettura di un modello maschile che non ha ancora saputo mettersi veramente in discussione superando gli stereotipi del passato (per crearne di nuovi ed efficaci) e, nel dubbio, preferisce o sparire o sagomarsi a un ruolo non suo; ma anche all’esigenza di una ricalibrazione del modello materno che, per necessità o legittimo riscatto, finisce per impossessarsi d’ogni spazio di intervento.
In questo contesto così articolato, la bigenitorialità si attesta, al di là di qualsivoglia naturalità o diritto, come una conquista culturale che, paradossalmente, fatica ad attuarsi soprattutto nelle famiglie unite, dove cioè la “normale” configurazione post-moderna dei ruoli non obbliga ad una riflessione in questo senso.
Culturalmente abiurato, e per fortuna, il vetusto padre-padrone, il maschile sembra faticare a ricavarsi un ruolo autentico e personale che non sia sagomabile al femminile o non si esautori nel semplice cambiare un pannolino, andare al parco coi figli, cucinare o lavare i piatti; bensì capace di immaginarsi quale artefice di un cambiamento generativo in un mondo estremamente differente da quello che, i maschi stessi, hanno disegnato per millenni.
Svuotato nelle sue dinamiche tradizionali, alla ricerca di nuove e possibili identità, il ruolo genitoriale, quando non è assunto quasi esclusivamente dal femminile per virtuale parricidio o abdicazione , al femminile finisce per riferirsi per linguaggi, comportamenti, visioni. Sia in un caso che nell’altro, potremmo dunque parlare di: “monogenitorialità”.
Ed ecco allora l’obversione.
E’, infatti, proprio laddove la crisi famigliare irrompe che papà e mamma frequentemente trovano (possono trovare, se ben accompagnati) l’occasione per mettere in discussione costruttiva e propositiva la loro genitorialità, conquistando un apogeo che la normale routine della vita familiare rischia di negare. Il che non vuol essere uno sprono al divorzio, né significa che le famiglie separate siano “migliori”; dovrebbe invece farci riflettere rispetto alla mancanza di un’educazione alla genitorialità che oggi pare diventare sempre più indispensabile e che solo nell’inciampo della crisi coniugale, può trovare l’occasione di riscoprirsi.
Da qui l’importanza della mediazione e di questo libro che bene la illustra, proprio addentrandosi nel fondamentale campo della relazione coi figli e del come affrontare, con loro, il discorso della separazione; non solo nel minuto spazio della tragica rivelazione, ma tanto più in quel tempo potenzialmente esiziale che è il prosieguo della vita da separati trasformandolo -appunto- nell'opportunità di costruire o ritrovare una genitorialità perduta o mai rivelata, nell'attesa che tale necessità irrompa anche nelle famiglie unite.
 Non è differenza da poco. E non tanto perché non ci si possa separare, per quel che mi riguarda, anche al ritmo di un divorzio ogni due settimane; ma perché, come bene ci insegnano le culture tradizionali, ogni separazione, pur consapevole che sia, comporta costi sociali e individuali: sul piano relazionale, psicologico e, non ultimo, economico. Costi che non possono essere ignorati o ridotti a effetto collaterale, ma necessitano di essere disciplinati, anzitutto, sul piano di un corretto e costruttivo accesso alla conflittualità, capace di non trasformare ogni separazione in quella guerra senza confini cui, purtroppo, le cronache ci hanno abituato.
Non è differenza da poco. E non tanto perché non ci si possa separare, per quel che mi riguarda, anche al ritmo di un divorzio ogni due settimane; ma perché, come bene ci insegnano le culture tradizionali, ogni separazione, pur consapevole che sia, comporta costi sociali e individuali: sul piano relazionale, psicologico e, non ultimo, economico. Costi che non possono essere ignorati o ridotti a effetto collaterale, ma necessitano di essere disciplinati, anzitutto, sul piano di un corretto e costruttivo accesso alla conflittualità, capace di non trasformare ogni separazione in quella guerra senza confini cui, purtroppo, le cronache ci hanno abituato. Non è differenza da poco. E non tanto perché non ci si possa separare, per quel che mi riguarda, anche al ritmo di un divorzio ogni due settimane; ma perché, come bene ci insegnano le culture tradizionali, ogni separazione, pur consapevole che sia, comporta costi sociali e individuali: sul piano relazionale, psicologico e, non ultimo, economico. Costi che non possono essere ignorati o ridotti a effetto collaterale, ma necessitano di essere disciplinati, anzitutto, sul piano di un corretto e costruttivo accesso alla conflittualità, capace di non trasformare ogni separazione in quella guerra senza confini cui, purtroppo, le cronache ci hanno abituato.
Non è differenza da poco. E non tanto perché non ci si possa separare, per quel che mi riguarda, anche al ritmo di un divorzio ogni due settimane; ma perché, come bene ci insegnano le culture tradizionali, ogni separazione, pur consapevole che sia, comporta costi sociali e individuali: sul piano relazionale, psicologico e, non ultimo, economico. Costi che non possono essere ignorati o ridotti a effetto collaterale, ma necessitano di essere disciplinati, anzitutto, sul piano di un corretto e costruttivo accesso alla conflittualità, capace di non trasformare ogni separazione in quella guerra senza confini cui, purtroppo, le cronache ci hanno abituato.